
Un tea with… Riccardo III
19 Marzo 2022
Sibilla Aleramo, scandalosa scrittrice femminista
21 Marzo 2022Djuna Barnes, bellezza e stile nella vecchia Parigi

Artista, scrittrice, suffragetta, giornalista e illustratrice americana. La sua opera letteraria più notevole è il romanzo Nightwood (1936): un pezzo fondamentale della letteratura modernista e uno degli esempi più eminenti di narrativa lesbica.
Nacque in giugno, nel 1892, morì in giugno, ribaltando le date, nel 1982; fu modernista, lesbica, vigorosa, austera, piaceva a Truman Capote ma anche a David Foster Wallace.
Donna d’impeccabile eleganza, dal viso squadrato, angolare, maschile, Djuna scrisse poco, con accuratezza. Ryder, del 1928, racconta la ferocia d’amare con una lingua che mescola l’epica biblica al caotico ( in Italia fu pubblicato da Bompiani). The Antiphon (1958), tragedia antimoderna, di bianca e grave levigatezza, piacque a Cristina Campo che dedicò alla Barnes un memorabile ritratto, privo di chiaroscuri, sul “Giornale d’Italia”, nel 1966, Una misteriosa americana che ebbe per araldo T.S. Eliot (raccolto in Sotto falso nome, Adelphi, 1998). “A mala pena si conosce un suo ritratto che, per essere perfetto, è già quasi una maschera funebre. Djuna Barnes vi appare in bianco profilo: un piccolo cappello nero le fascia il capo, lascia ricadere oltre il profilo, dritta come una griglia di carcere, la grossa rete di un velo nero. Il labbro inferiore asburgico ne sporge un poco, e il naso perfetto, desolato, inclemente.”
Passava molti pomeriggi e serate nei caffè lungo il boulevard du Montparnasse con indosso una lunga mantella da sera che in origine era appartenuta a Peggy Guggenheim, Barnes si perdeva a lungo nei propri pensieri osservando le attività della strada. Anche se in seguito affermò di avere sprecato quegli anni, in realtà scriveva regolarmente.
Nella sua lunga vita, Djuna Barnes pubblicò sette libri e sperimentò vari generi – compresi poesia, racconti, opere teatrali, saggi brevi e articoli giornalistici, oltre alle recensioni teatrali – e fu ritrattista e illustratrice delle proprie opere. Tra i suoi primi scritti, l’unico letto e ricordato era La foresta della notte, in parte perché l’introduzione di T. S. Eliot (per la quale Barnes nutriva sentimenti ambivalenti) esortava gli studenti di letteratura a prendere seriamente l’opera, e perché il romanzo attirò un seguito alternativo, divenendo parte della cultura del “campeggio” tra i ventenni parigini. La sua reputazione come figura di culto dell’epoca fu accentuata forse dal fatto che la sua opera, come quella di molte altre scrittrici moderniste espatriate, per parecchi anni andò fuori stampa a periodi alterni. Nel 1962 uscì Selected Works of Djuna Barnes, e a metà degli anni Settanta gli studiosi cominciarono a pubblicare analisi esaustive della sua produzione.
Negli ultimi anni – tanti – a Patchin Place, tra la Sixth Avenue e Greenwich, visse da reclusa. Carson McCullers si accampò sotto casa sua per incontrarla; E.E. Cummings gli spediva dei biglietti con la stessa frase, replicata in centinaia, “Sei viva, Djuna?”. Sul campanello di casa aveva applicato un nastro, “Se intendi suonare il campanello, vattene!”. Non pubblicò più nulla, scrisse per sé, nessuno riuscì a censirla, a classificarla.
I LIBRI IN BOOKBANK
BOSCO DI NOTTE
Questo romanzo, pubblicato nel 1936 con una presentazione di T.S. Eliot, ci
appare oggi, fra i grandi libri del nostro secolo, come un essere solitario,
esotico e fiero. Qui, sin dall’inizio, l’aria del tempo ci avvolge in una fosca
cappa: siamo nella Parigi dissipata degli Anni Venti, che si abbandona alla
«grande inquietudine detta divertimento», o ci aggiriamo per un’Europa che si
offre come una polverosa, opulenta esposizione di bric-à-brac, in attesa
dell’inventario. Ma presto avvertiamo che c’è anche una forte distanza dai
tempi e dai luoghi: un vento metafisico turbina in queste pagine e solleva le
immagini in mulinelli incessanti. La mescolanza intima fra crudezza e
concettosità, che fu il prodigio degli Elisabettiani, risorge nella prosa della
Barnes, dove le parole sembrano incurvarsi nelle spire di un puro delirio
ornamentale, per trafiggere poi con sentenze mortali.
Al centro della Foresta della Notte dorme la Bella Schizofrenica, in un letto dell’Hôtel Récamier. È Robin: la sua carne ha una «grana arborea», il suo corpo esala il «profumo dei funghi», la sua epidermide è azzurrata, come da un fluido sottocutaneo. «Creatura selvaggia intrappolata in una pelle di donna», Robin porta ovunque la calamità e la fascinazione, procedendo con passo da sonnambula sempre più in là nella sua depravata innocenza. Intorno a lei vediamo disporsi, come in un quadrilatero di polene abbandonate, gli altri personaggi del romanzo: Nora, che cela nel suo cuore «il fossile di Robin», quasi una memoria ancestrale; la rapace Jenny; il falso Barone Volkbein, pateticamente devoto a una nobiltà fantomatica. Ma su tutti torreggia il dottor Matthew O’Connor, ciarlatano mistico, Guardiano della Notte, il cui sontuoso e corrusco blaterare si contrappone alle rare e monche parole di Robin. Il dottor O’Connor ci viene incontro come un cliente pittoresco del Café de la Mairie du VI° e sentiamo, per così dire, la sua voce echeggiare da tutti i bar perduti degli Anni Venti. Ma nella sua apparizione riconosciamo anche una voce perenne, penetrante, ossessiva, che continuerà a parlare «finché la furia della notte non avrà fatto marcire fino in fondo il proprio fuoco». È una figura indelebile, un dottore non della malattia, piuttosto del «male universale»: quel male che non guarisce, ma vuole disperatamente chiamarsi per nome – e quel nome è la letteratura.
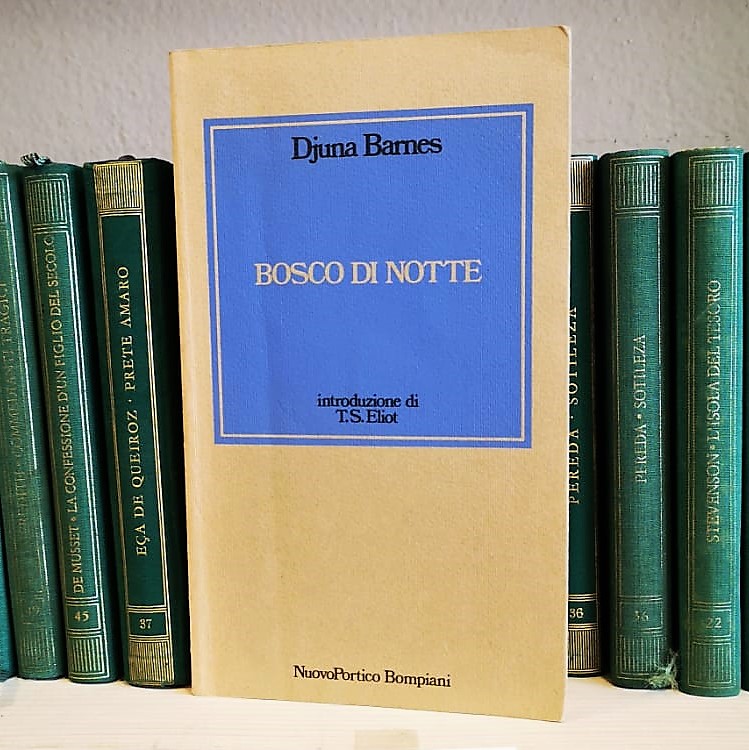
I LIBRI IN BOOKBANK
FONTI:
PANGEA
SENTIERI SERRATI




